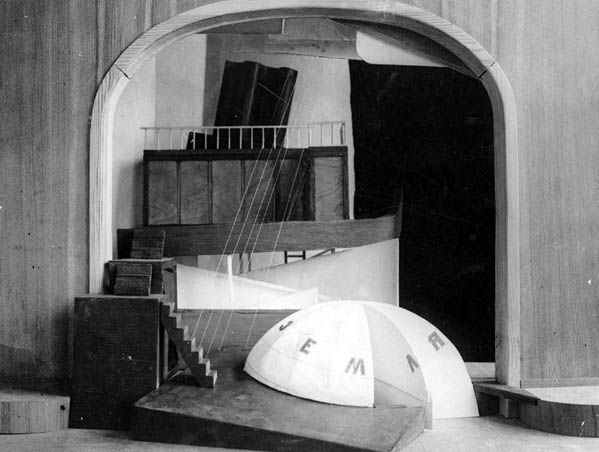Pensare il sé in termini d’identità significa trovare le ragioni profonde della sua sussistenza. Locke è stato il primo filosofo a interrogarsi sulla natura dell’identità individuale e sulla ragione della sua permanenza malgrado i mutamenti che coinvolgono il soggetto nel corso dell’esistenza.[1] Ma posta in questo modo, la domanda sull’identità del soggetto rivela già l’assunto d’essenzialità su cui si fonda: rintracciare le condizioni necessarie dell’identità significa ipostatizzare il sé concependolo in quanto ente autonomo e sussistente. Seguendo il ragionamento di Locke, tra identità e memoria vi sarebbe un legame di convergenza fattuale, da cui egli ricava l’identificazione tra essenza del sé e ricordi autobiografici: ciò che garantisce la permanenza del soggetto e il suo senso d’identità sarebbe proprio la memoria autobiografica. In una tale prospettiva, perdere i ricordi significa scomparire del tutto, smettere di esistere, non a seguito del sopraggiungere della morte fisica, quanto più per effetto della desoggettivazione che annienta il soggetto e la sua coscienza di essere al mondo. Tale costrutto filosofico permea di senso anche le nostre semantiche della soggettività e condiziona intimamente i modi di vivere e di raccontare l’invecchiamento. L’esperienza della demenza senile risente infatti del particolare tono drammatico con cui coloriamo tutte le sue infinite narrazioni.
A differenza di Locke, Paul Ricoeur, con la sua celebre teoria dell’identità narrativa, pur inserendosi nella tradizione del pensiero occidentale che stabilisce una relazione di coincidenza ontologica e psicologica tra identità e memoria, propone una definizione costruttivista dell’io. Per il filosofo francese l’identità, lungi dall’essere un ente stabile e definito, è invece il risultato di un processo che dura tutta la vita e che trova nel racconto autobiografico la sua ragione più profonda.[2] La narrazione autobiografica, che spinge l’individuo a riflettere sul proprio passato alla luce del presente mentre già si prepara a progettare il futuro, permette di individuare una coerenza logico-cronologica tra i ricordi delle proprie azioni e l’immagine di sé. Tra identità e memoria non c’è più una coincidenza perfetta, istantanea e stabilità una volta per tutte. La memoria autobiografica infatti non si può ridurre a una mera collezione di ricordi giustapposti e il racconto di sé diventa una vera e propria performance, una perpetua messa in scena della propria identità narrativa nel momento stesso in cui essa, narrandosi, si rivive e si costruisce. Tuttavia, anche Ricoeur, che concepisce l’identità in quanto vera e propria fiction narrativa, nonostante si sbarazzi della sostanzializzazione dell’identità, continua ad assegnare alla memoria un ruolo centrale nel processo soggettivazione.
Ancora una volta, quindi, chi non ricorda il proprio passato, o ricorda in modo impreciso e lacunoso, si espone al rischio della perdita del sé e del proprio statuto di soggetto. Incapace di percepirsi come soggetto della propria azione nel passato, l’individuo che perde la memoria è potenzialmente esposto all’implosione della linearità del proprio tempo autobiografico. Per noi infatti il soggetto è sempre soggetto d’azione, cioè un individuo che riconosce se stesso come soggetto della specifica azione del passato sulla quale è in grado di riflettere nel presente. Tale struttura lineare del tempo risente anche del nostro modo di concepire la causalità fattuale: tra due eventi di cui l’uno segue temporalmente l’atro, il primo evento, quello che consideriamo passato, diventa per noi causa dell’altro evento. Questo spiega perché l’individuo che non ricorda il proprio passato, sente di perdere anche il proprio futuro : perduta l’immagine lineare del tempo, si perde il nesso di causalità tra presente, passato e futuro e si dissolve la capacità di cogliersi in quanto causa soggettiva di tutte le proprie azioni. Se esiste una somiglianza reale ed epistemologica tra il tempo della vita e il tempo del racconto,[3] perdere la nozione di temporalità significa perdere non solo la capacità di raccontarsi, ma anche la possibilità di vivere davvero, cioè di vivere come soggetto cosciente di sé e della propria esistenza. La vita perde la propria temporalità trasformandosi in un presente eterno e immobile che presagisce e preconizza la morte. A dissolversi nel nulla è l’idea stessa di un soggetto che entra in relazione con altri soggetti sulla base di una storia comune, fatta di narrazioni condivise e condivisibili. La demenza senile ci forza a fare i conti con la paura del vuoto e del nulla; non la morte, dunque, ma la perdita del soggetto, la sua esistenza desoggettivata che si tramuta nel paradosso di un essere inesistente. Nemmeno la crisi della presenza ci aiuta a chiarire il significato di questo nulla assoluto perché non si può destoricizzare qualcosa che sfugge del tutto alla logica del tempo.[4]
Per capire come la nostra società ha prodotto una concezione tanto tragica quanto inintelligibile della demenza senile occorre analizzare il rapporto ch’essa ha intrattenuto nel corso della storia con la figura dell’anziano e con quella del morente. Secondo Norbert Elias, la diffusione delle pratiche d’igienizzazione del comportamento e di sanitarizzazione degli spazi abitativi nella vita quotidiana ha prodotto l’isolamento dei malati e dei morenti in luoghi specificamente preposti alla cura e al trattamento.[5] In questo modo, l’uomo ha allontanato da sé la morte, espugnandola dalla dimensione dell’ordinario e rendendola invisibile allo sguardo. Invece, negli ultimi cinquant’anni, in seguito al sempre più generale miglioramento delle condizioni sociosanitarie della popolazione e alla crescente estensione della speranza di vita nelle società del benessere, i paesi ricchi stanno vivendo quella transazione demografica che è alla base di una massiccio invecchiamento della popolazione. Questo fenomeno ha reso la morte ancora più opaca alla nostra coscienza collettiva.
Negli ultimi decenni, i dibattiti politici e i discorsi mediatici che affrontano la questione dell’invecchiamento demografico individuano in particolare due fenomeni che la sanità pubblica è costretta a gestire: da una parte, la diffusione delle malattie croniche legate all’invecchiamento e l’esigenza di un profondo mutamento delle politiche sanitarie che prevedano cure a lungo termine e supporto alle famiglie degli anziani e, dall’altra parte, il dramma della demenza senile sempre più alla ribalta in seguito alla diffusione di proporzioni “epidemiche” di disturbi cognitivi e malattie neurodegenerative. Il primo problema riguarda la cura del corpo a garanzia della sopravvivenza e della salute, il secondo invece rimanda più propriamente alla questione bioetica della qualità della vita rispetto al valore assoluto o relativo da assegnare alla vita umana: la vita umana ha valore in sé? Oppure il suo valore è sottoposto a determinate condizioni ? E’ meglio vivere il più a lungo possibile o è meglio conservare benessere e lucidità fino alla morte? E infine, quale vita è per noi degna di essere vissuta? Sono queste e molte altre le domande a cui siamo chiamati a rispondere oggi. L’invecchiamento demografico se ha distolto l’attenzione dalla morte, ha portato sotto il nostro sguardo uno scandalo ancora peggiore: l’insorgere della demenza ci fa temere per l’annientamento del soggetto ancor prima che la morte stessa possa sorprenderlo.
Siamo di fronte alla più spinosa aporia gnoseologica, etica e spirituale del nostro tempo che mette in crisi credenze e valori intorno a cui abbiamo forgiato le diverse definizioni della vita umana. Emerge il bisogno di una nuova etica della cura che non consideri solamente l’assetto biologico dell’invecchiamento, della malattia e della demenza, ma che faccia i conti con la dimensione metafisica e spirituale dell’esistenza. Di conseguenza, l’invecchiamento della popolazione non è solo un dato demografico né una mera problematica socio-sanitaria che richiede interventi politici e investimenti economici. E’ piuttosto un problema di carattere culturale che entra in rapporto con la dimensione della spiritualità e della trascendenza.

Le posta in gioco è alta se si pensa che l’esperienza della malattia, dell’invecchiamento e della demenza è fortemente condizionata dal modo in cui tali esperienze vengono interpretate. A loro volta, queste interpretazioni sono impregnate di rappresentazioni ed ermeneutiche condivise, di racconti sulla vita e sulla morte, di saperi e di pratiche che fino a oggi sono state elaborate, conservate e trasmesse. Ma l’invecchiamento della popolazione ci ha messo di fronte a un’espressione della condizione umana per noi nuova e sconosciuta, per cui non disponiamo ancora di simboli, codici e criteri d’interpretazione che possano in qualche modo rendercela pensabile, comprensibile e accettabile. Ciononostante, gli anziani malati e clinicamente dementi sono sempre più visibili. Essi fanno ormai parte del tessuto di relazioni quotidiane, di scenari di eventualità sempre più probabili, di trame narrative che ci riguardano da vicino. La loro esistenza non può essere negata, né la loro presenza confinata ad uno spazio extra-ordinario così come in passato abbiamo potuto fare con i moribondi. Il nostro sguardo non può più esimersi dal vedere quest’alterità prossima, che ci richiama ai nostri doveri di cura e sfida le nostre più consolidate certezze sul significato dell’esistenza e sulla definizione della condizione umana. La demenza è oggi una realtà con cui dobbiamo sempre più probabilmente fare i conti. Essa ci coinvolge come soggetti o come oggetti di cura e nessuno dei due versanti di questo rapporto sembra metterci al riparo dal senso di precarietà di fronte al quale l’individuo contemporaneo si ritrova denudato di se stesso.
Nel romanzo da cui siamo partiti, Le Correzioni di Jonathan Franzen, Alfred, malgrado la qualità infima dei rapporti familiari, è compatito, compianto, fatto oggetto di attenzione e cura da parte di tutta la famiglia Lambert. La qualità dell’amore filiale e la sincerità dell’affetto coniugale non sono condizioni necessarie ad innescare il processo di cura. Alfred non gode di alcuna buona considerazione da parte della moglie e dei figli, eppure questo non li risparmia dal sentire un profondo senso di responsabilità. Nessun valore intrinseco alla persona, positivo o negativo che sia, sembra giocare un ruolo importante nell’insorgere del rapporto di cura. La cura verso l’anziano alienato nel solipsismo della propria demenza non è legata a quell’inestinguibile “debito di vita” che vincola i figli a essere eternamente riconoscenti verso i propri genitori.[6] Esso non dipende nemmeno dall’amore coniugale. Qui il rapporto di cura si carica di una valenza sacrale superando la reciprocità mondana che definisce ogni relazione. Eppure Enid e i figli sperimentano un senso di dovere che oltrepassa il livore e la rabbia provati per quell’uomo.
Questo dovere di cura si tramuta in dono gratuito. Le colpe del passato si rimuovono in nome di un presente dominato dall’eternità della demenza. Per questo la cura di Alfred supera i confini dello scambio, va al di là dei meriti e delle ricompense, ben oltre la logica classica del dono maussiano:[7] l’hau, lo spirito della cosa donata, sembra scomparire, ma invece si smaterializza soltanto, si spoglia dell’oggetto, si svincola dal valore che possiamo attribuirgli, fa meno della cosa donata e torna a essere puro spirito. Eppure non si tratta nemmeno di semplice altruismo incondizionato, giacché il dono gratuito racchiuso nella cura verso l’anziano è pur sempre stretto al vincolo della sua stessa gratuità. L’anziano affetto da demenza senile pur non essendo definibile come oggetto, è già in partenza un non-soggetto : la demenza lo ha già desoggettivato.
Producendo un non-soggetto che è a un tempo anche un non-oggetto, la demenza confina l’individuo nella sfera della pura negazione. Ed è in virtù di tale negazione che non risulta nemmeno possibile pensare alla demenza come portatrice di valore. Infatti, secondo la logica della grammatica narrativa di Greimas, se il soggetto ha valore in sé, l’oggetto ha sempre un valore estrinseco che serve a definirlo come oggetto di valore.[8] Ma al demente alcun valore può essere attribuito: essendo un non-soggetto non può avere valore in sé e, nel frattempo, in quanto non-oggetto non può essere nemmeno un oggetto di valore. Nella nostra cultura antropocentrica e razionalista, che fonda le basi della costruzione dell’identità e del processo di soggettivazione sui dati autobiografici conservati nella memoria, nessun valore, sia esso positivo o negativo, è assegnato a chi, affetto dalla demenza senile, ha perso coscienza della propria esistenza temporale e della linearità logica e cronologica della propria identità narrativa. La figura dell’anziano vittima della demenza rappresenta l’ultima e più radicale forma di desoggettivazione contemporanea, l’ultimo e più terribile scandalo: la perdita del sé, la dissolvenza di un soggetto che sopravvive alla sua stessa morte.
[1] LOCKE, John, Un Essay Conserning Human Understanding, Londra, The Baffet, 1989.
[2] RICŒUR, Paul, Temps et récit, tome II, La configuration dans le récit de fiction, Le Seuil, Paris, 1985.
[3] RICŒUR, Paul, Temps et récit, tome III, Le temps raconté, Le Seuil, Paris 1985.
[4] DE MARTINO, Ernesto, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, Il Saggiatore, Milano, 1961.
[5] ELIAS, Norbert, La solitudine del morente, Il Mulino, Bologna, 1985.
[6] MEILLASSOUX, Claude, « A chi dobbiamo la vita », in: Solinas P. G. (a cura di), La vita in prestito. Debito, lavoro e dipendenza. Argo, Bari, p. 31-44.
[7] MAUSS, Marcel, Essai sur le don, La République des Lettres, Paris, 1923.
[8] GREIMAS, Algirdas Julien, La semiotica strutturale : ricerca di metodo, Meltemi, Roma,1974 (ed. originale: La sémantique structurale : recherche de méthode, Larousse, Paris, 1966).