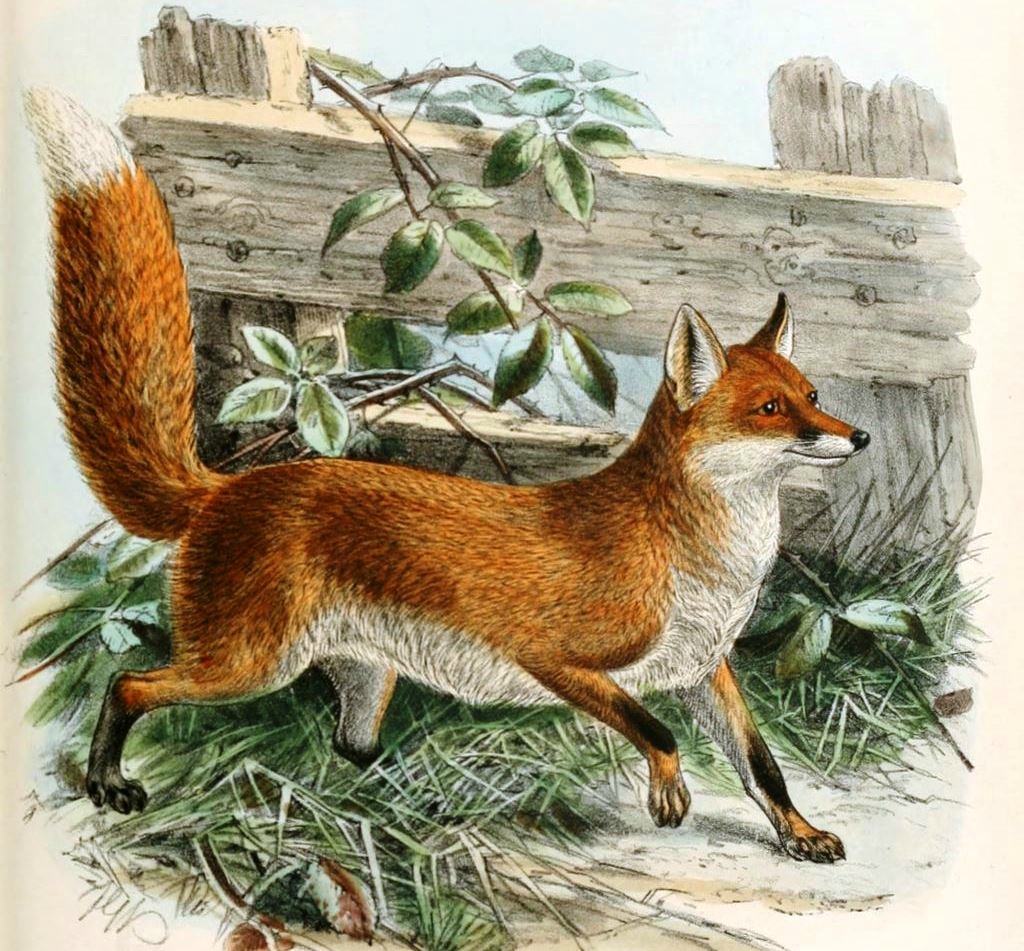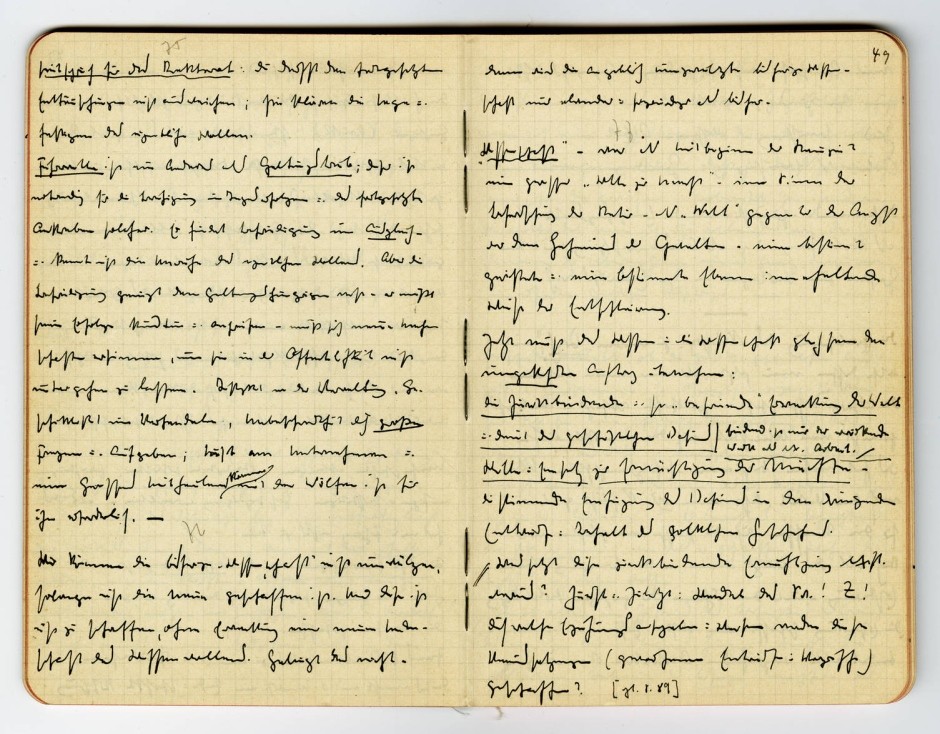Φιλαπεχθήμων
L’Abbaglio
Che si sia trattato di un abbaglio lo scrive Heidegger stesso in una lettera ad un’amica della moglie Elfride, Elisabeth Blochmann. Con Elisabeth, dagli anni Venti in poi, Heidegger ebbe una lunga corrispondenza. Elisabeth, ebrea e nazista convinta, dovrà emigrare in Gran Bretagna. Heidegger stesso si darà da fare per trovarle una sistemazione come studiosa di pedagogia, a Cambridge. Tanto era nazista convinta che, agli inizi, faticherà a comprendere il perché non venissero capite dagli inglesi le sue ragioni di adesioni al nazismo (da cui comunque era stata esiliata; continuava cioè evidentemente a considerare l’antisemitismo nazista come un eccesso contingente, e non fondativo, com’era). Tornerà in Germania nel dopoguerra, come docente di pedagogia, molto cambiata, al punto da confessare che la tonalità esaltata della corrispondenza con Heidegger dei primi anni le è ormai estranea, i cui fiammeggianti discorsi le erano spesso, già allora, incomprensibili.
Ma è la comune adesione al nazismo a rendere particolarmente rilevante, in quanto riservato, solo tra di loro e per di più unico, il passaggio di una lettera dell’inizio del 1947, in cui Heidegger si domanda se sia possibile: “semplicemente…contrapporsi all’esplosione dell’inumano che non abbiamo subito riconosciuto nella sua astuzia e a cui troppo sconsideratamente abbiamo lasciato il gioco del potere» [sott.; cors.;grass.- Φ]. L’esplosione di cui si tratta che non è stata riconosciuta nel passato, non può che essere il nazismo. Come dice in un’altra lettera del marzo 1948: ”Già dalle esperienze del 1933 [e quale altre possono essere se non nazismo e Rettorato? – Φ] mi è divenuto chiaro che le nostre concezioni europee correnti non sono sufficienti per pensare ciò che è già da tempo – ed è deciso”.
Ma forse più importante è chiedersi se si possono dare dei perché per quell’abbaglio. Sempre alla Blochmann scrive nella stessa lettera del 1947: «resta la domanda, se questa realtà sia un inizio oppure solo la fine di un processo che da tre secoli definisce l’epoca come età moderna. Gli avvenimenti che oscurano il pianeta non possono essere gli artifatti di singoli uomini, che fungono solo da sgherri» [sott-Φ]. Qui sta probabilmente la radice dell’abbaglio. Nella domanda retorica del periodo è implicito che, giunti a quel punto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Heidegger ritiene quel processo sia appena all’inizio. Ma allora quando gli può essere apparso come fine? Ovviamente prima della guerra, in quel ventennio di sconvolgimenti segnati da Tempeste di acciaio. Aver scambiato un’alba per un tramonto è la radice dell’abbaglio. Le cose erano appena iniziate. Se solo con il nazismo la Germania incontra la tecnica, come dice Heidegger, allora era un’inizio. Aver pensato che il nazismo fosse il segno della fine dell’eone, una fine anticipata e desiderata (tutta la meditazione della svolta è rivolta al nuovo inizio); in questo era consistito il suo abbaglio. Questi abbagli non sono rari. Tutti noi abbiamo pensato che la grande arte degli anni Venti e Trenta fosse un’alba, e invece era un tramonto. Anche Marx pensava che il capitalismo che aveva sotto gli occhi fosse alla fine, e invece era all’inizio; il movimento socialista non ne stava accelerando la fine, come pensava, ma forse stava accelerando solo la fine del cominciamento dell’inizio.
I Prigionieri
Gli anni Trenta europei vedono uno strano pullulare di prigionieri dei propri amici. Fatto che ricorda il titolo di un film del regista russo Michalkov, Nemico tra gli amici, amico tra i nemici.
Ci suggerisce il fenomeno Carl Schmitt che, in Ex captivitate salus, fa un parallelismo tra la propria situzione durante il nazismo e quella descritta nel romanzo breve di Melville, Benito Cereno, che racconta di una rivolta di schiavi a bordo di una nave che li trasportava. Il racconto di Schmitt suscita sulle prime un po’ di diffidenza, alimentando un sospetto di retorica autoassolutoria. Eppure, guardandosi intorno, si vede una molteplicità di casi che presentano caratteristiche analoghe.
Peraltro, anche riferendosi a Schmitt, si coglie un elemento di verità. E la si coglie, paradossalmente dove appare più allineato al regime. Bisogna partire dall’idea che Schmitt è uomo di destra, ostile al mondo liberale. E’ la cecità del liberalismo alla tragicità del ‘politico’ che suscita il suo antagonismo intellettuale (ma qualcuno, prima o poi dovrà interrogarsi sulla strana duplicità del liberalismo: efficienza pratica & superficialità teorica. Che – in epoca di mobilitazione di massa – sia necessario rimuovere la radice dei problemi per poterli affrontare? Che nell’atteggiamento opposto stia la tragedia dell’impotenza del realismo politico?) Ma non poteva essere il nazismo la sua soluzione: troppo ctonio, per un aristotelico romano. La sua soluzione era piuttosto l’ex-Capo di Stato maggiore tedesco Kurt von Schleicher, ucciso nel giugno 1934 nel quadro della vendetta di Hitler sui suoi nemici politici – la notte dei lunghi coltelli. Schmitt aveva difeso dottrinalmente nel 1931 la linea propugnata da Schleicher dell’uso dell’art. 48 della Costituzione di Weimar per giustificare l’esercizio di poteri eccezionali del Presidente della Repubblica. In quell’occasione mise in guardia contro coloro che, giunti al potere secondo le regole, si chiudono la porta dietro, impedendo ad altri di contestarglielo (difficile pensare che avesse in mente altri che i nazisti). Eppure quando Schleicher fu ucciso scrisse un articolo dal titolo Il Führer difende il Reich, apparentemente di approvazione, o quantomeno di accettazione dell’assassinio. Articolo che però, guarda caso, ai nazisti non piacque. Forse nella paradossalità dell’articolo e del suo titolo, è celato il lato ‘Benito Cereno’ della situazione? Poteva attaccare? Impossibile: conosceva bene i nazisti; inoltre, non era un oppositore, e certo non in nome della democrazia liberale o del socialismo. Poteva solo ‘dissentire’ eccedendo nell’approvazione, conoscendo bene l’ossessione dei nazisti per la dissimulazione (di cui scrisse; e come si vide anche nella loro conduzione della ‘soluzione finale’). Così visse, da prigioniero di amici.
Ernst Jünger è forse un altro caso simile. Protagonista della Rivoluzione conservatrice, attraversò il nazismo senza aderirvi attivamente (rifiutò sempre la direzione dell’associazione degli scrittori nazionalsocialisti che Göbbels gli offrì ripetutamente); ebbe qualche guaio per collaborazionismo, ma neppure troppi (meno di Heidegger, comunque). I due saggi, La mobilitazione totale e Il lavoratore basati, come sostiene Heidegger, su una metafisica della volontà di potenza di origine nietzschiana, parlano di una svolta epocale, il cui nucleo non si attaglia solo ai nazisti; per quanto questi siano sicuramente – anche se non i soli – il partito della mobilitazione totale. Non poteva che stare con loro, dato il pregresso di esperienza storico-politica: dalla Prima Guerra Mondiale alla breve esperienza nei Freikorps. In fondo un alleato scomodo, ma protegé, più di Heidegger, ma con meno noie dopo. Anche lui in qualche modo prigioniero tra amici. (Sia ben chiaro, questo giudizio è un lusso che ci si può permettere di formulare solo grazie alla distanza storica. Subito dopo i fatti non si poteva che chieder conto della cecità e della contiguità col nazismo)
Un altro personaggio soggetto a una strana prigionia è Karl Jaspers. Non si vuole qui assolutamente mettere in dubbio il suo essere anti-nazista – anzi, è stato tra i giudici anti-collaborazionisti nel dopoguerra – e quindi le ragioni politiche (che seguono cronologicamente quelle filosofiche) del raffreddamento con Heidegger. Si vuole solo mettere a fuoco un aspetto che fa di lui un prigioniero, tra nemici stavolta, ma in modo strano. Jaspers, durante tutto il periodo nazista, è vissuto in Germania, è emigrato solo nel dopoguerra, con un gesto di rifiuto del paese veramente significativo. E aveva anche una moglie ebrea. Eppure non gli successe nulla. E ci si può chiedere come mai. Perché non è emigrato? Molti lo fecero, e i nazisti li lasciarono andare. Era ostaggio? Perché? Ma pur ricadendo sotto le durezze delle leggi razziali, ed essendo a intermittenza minacciato, non fu mai toccato, né lui né la moglie ebrea. Non si può fare nient’altro che una congettura. Che forze interne di stampo liberale, che pure avevano permesso ai nazisti la presa del potere, lo abbiano protetto perfino nel periodo 1939-42, in cui lui temette di più, giustamente, perché ormai la guerra aperta esimeva i nazisti dal rispettare accordi precedenti (difficile pensare che, in quelle condizioni, un qualsiasi funzionario nazista, a qualsiasi livello, non avesse voluto, potendolo, appuntarsi senza sforzo la medaglia del suo internamento; chi avrebbe mai difeso un marito di moglie ebrea, e la moglie stessa? E perché mai?). Un prigioniero tra i nemici, ma protetto da (ignoti) amici.
Caso simile, ma ancora più chiaro, quello di Benedetto Croce in Italia. Inizialmente vicino al fascismo, se ne distaccò dopo il delitto Matteotti. Ma la sua opposizione fu sempre mantenuta in ambiti ideal-filosofici, e ristretta in ambienti sociali elitari, come quelli che potevano gravitare intorno alla sua rivista La critica liberale. Anche se per varie ragioni, il regime fascista non raggiunse mai la chiusura totalitaria del nazismo, comunque Croce va considerato un prigioniero, protetto da varie forze, tra cui probabilmente anche la Monarchia.
Ma il fenomeno dei prigionieri non riguarda solo la destra europea. Cos’era il buchariniano Togliatti, per quanto dirigente del Komintern, all’hotel Lux a Mosca? Un prigioniero di una linea politica, emanante da Stalin, di cui aveva accettato con glaciale lucidità l’inevitabilità storica, dandosi il compito di salvare il suo partito (cui assegnò il compito di cambiare l’Italia radicandolo nel pensiero politico del compagno di lotta Gramsci) dalle tragedie della purghe staliniane, in cui scomparirà ad esempio il partito comunista polacco (oltre che lo stesso Bucharin e tanta parte della direzione storica del partito bolscevico – cioè la frazione socialdemocratica maggioritaria – russo). Tornato in Italia si parlerà molto della doppiezza togliattiana, intendendo che parlava di democrazia e pensava alla rivoluzione; ma Pietro Ingrao, testimone di quei tempi, sosterrà che la doppiezza andava letta all’inverso: parlare di rivoluzione e intendere democrazia. Per non parlare di Gramsci, doppio prigioniero, di nemici, il fascismo, ma anche di amici; come quando a Turi, al confino, si trovò isolato, e guardato con sospetto, dagli altri compagni di partito in confino che avevano accettato senza riserve la svolta del socialfascismo del VI Congresso del Comintern. Si è molto polemizzato sulla presunta mancanza di iniziativa togliattiana per raggiungere un accordo con Mussolini per liberarlo. Ci sono stati di recente interventi importanti come quelli di Vacca e Canfora a chiarimento di punti controversi. Qui si porrà una sola domanda: se fosse stato liberato negli anni Trenta, dato il pregresso – la lettera contro la direzione politica Stalin-Bucharin del 1926 che Togliatti non rese nota, e il dissenso nei confronti della linea del socialfascismo nel 1929 – sarebbe sopravvissuto Gramsci a Mosca durante le purghe degli anni Trenta? Forse c’è davvero una zona grigia. Forse Togliatti afferrava meglio la situazione.
Solo sullo sfondo degli anni Trenta come decennio di prigionieri tra gli amici si può capire meglio il caso Heidegger. Che Heidegger sia stato politicamente di destra è ampiamente noto. Che per anticonformismo, e un tratto personale antiborghese, potesse guardare con simpatia alla Rivoluzione conservatrice, ai caratteri eversivi ‘anti-borghesi’ del nascente nazismo (presenti anche nel futurismo e nel fascismo) e alle sue promesse di smantellare le consorterie tradizionali, è abbastanza scontato.
Ricordiamo comunque che l’ascesa politica del nazismo – da partitino al margine a forza politica nazionale – fu drammaticamente rapida, dal 1931 al 1933, laddove Heidegger diventa una figura filosofica mondiale a metà degli anni Venti, ben prima dell’affermarsi pubblico del nazismo. Dal 1923 al 1929 Hitler è solo un caporale austriaco, un pittorucolo fallito, che insieme a un generale già glorioso, ma emarginato, Lundendorff, ha tentato un putsch a Monaco, partendo da una birreria. É solo il 1929 che trasforma Hitler in Hitler, come altrove ha trasformato Keynes in Keynes. Aggiungiamo che la pericolosità del movimento non fu capita quasi da nessuno; certo non dal Segretario di Stato del Vaticano, mons. Pacelli che, nonostante gli undici anni passati in Germania come Nunzio, o forse proprio per quello, permise ai nazisti di raggiungere il quorum necessario per il Machtergreifung del 1933 solo grazie ai voti del partito cattolico del Centrum. Né sollevò particolare inquietudine l’antisemitismo totale – fino all’estrema conseguenza dell’annichilazione – enunciato in Mein Kampf (perfino in ambienti ebraici la cosa fu sottovalutata). E’ impressionante la cecità di fronte al fenomeno Hitler che emerge dalle dichiarazioni pubbliche sul tema – in tutti i paesi europei e su tutto lo spettro politico, dal 1931 al 1933 – raccolte dallo storico Alfred Grosser (troppi ragionano a partire dalla conoscenza che ne abbiamo oggi). Solo Simone Weil fece eccezione.
Diciamo che Heidegger fu colpevole di un temporaneo entusiasmo per il nazismo in un quadro di cecità pubblica – la norma in quel periodo – rispetto alla sua pericolosità. Da cui l’accettazione di una vicinanza che lo portò al famigerato Rettorato del 1933, da cui si dimise nel 1934. Se scandalizza così tanto l’abbaglio in un pensatore, cosa dovremmo dire di un futuro Papa? E perché mai l’adesione di Heisemberg al nazismo, duratura, convinta, secondo la testimonianza di Niels Bohr – e che solo per caso non giunse alla produzione per Hitler della bomba atomica – è generalmente rimossa? L’adesione al nazismo fu breve, ma gli effetti furono devastanti. D’altronde, mettiamoci nei panni di allievi di tutto lo spettro politico, ebrei e non ebrei. L’incomprensione del nazismo è una cosa, ma coloro che si sentivano oggetti dell’odio totale dei nazisti non potevano che ricambiare. Che, in queste correnti di odi politici un venerato maestro si mettesse da quel lato non poteva che sconvolgere.
Peraltro il discorso di Rettorato esemplifica alla perfezione quello che Hannah Arendt scrisse in occasione dell’ottantesimo compleanno di Heidegger: Heidegger la volpe, così astuto che si mette in trappola da solo. In un discorso, come quello, peraltro ampiamente frainteso per superficiale malafede, ma politicamente necessariamente allineato (Per convinzione? In parte certamente si. Peraltro, se non lo fosse stato affatto, che senso avrebbe avuto accettare la carica; non solo per sè, ma per i colleghi che gliel’avevano chiesto?) Heidegger interpola due passaggi agli antipodi (il lato Benito Cereno della vicenda) della politica e della volontà dei nazisti riguardo l’università e la cultura: a) la scienza non dev’essere politica, come invece voluto dal partito; b) tra i vari servizi enumerati, quello del sapere dev’essere il primo; e neppure questo poteva piacere al partito, anzi. Ci sono biblioteche sul nazismo di Heidegger, pro o contro, o forse più contro che pro. E’ inutile tentare di attraversarle. Un autore che nell’incipit dell’Origine dell’opera d’arte del 1935-36 (anni del trionfo nazista, e della prospettiva del Milleminium del Reich) inizia parlando degli scarponi in un quadro di Van Gogh (arte degenere quant’altre mai) non ha, non può avere, nulla di spiritualmente in comune con il nazismo. Inoltre, già nel Rektoratrede e successivamente insisterà nel dire che la parola necessaria al popolo tedesco per installarsi nella sua storicità è quella di Hölderlin; sottolineando per di più (in una lettera alla Blochmann) la “falsa attualità” di certe espressioni del poeta, ovviamente per differenziarsi da possibili letture naziste. Certo, in privato; mantenendo una possibile ambiguità pubblica (il suo lato di volpe). Concludendo, un prigioniero del proprio abbaglio. Come gli altri prigioniero in e di un’epoca di mobilitazione totale, la caratteristica epocale che è all’origine di quelle prigionie.
Il Perdono
Nel dopoguerra Heidegger fu fatto oggetto di innumerevoli richieste di autocritica. Certo ci fu una notevole dose d’orgoglio nel suo silenzio. Come ci fu una notevole dose di invidia e malanimo nel farle. Così come sono eruditamente illogiche le argomentazioni che tracciano parallelismi tra il nazismo e il pensiero di Heidegger. ovviamente rimuovendo il banale fatto che il percorso fondamentale di Heidegger fino agli inizi della svolta (nei Problemi fondamentali della fenomenologia) è già attuato nel 1927 (quando l’NSDAP era un partitino extraparlamentare, senza alcuna audience di massa). Dopo ci sarà solo il lungo cammino a partire dal naufragio. Che poi quel pensiero abbia preparato il nazismo, il non voler prendere sul serio il fatto che Heidegger considerasse le elaborazioni ‘teoriche’ dei nazisti (v. Rosemberg) come deliri, è una tesi segno solo di malafede. (O qualcuno pensa che ogni bravo membro delle SA o SS tenesse Sein und Zeit sul comodino. Assurdo). Malafede che consiste nel non voler distinguere un’adesione contingente al ‘partito’ nazista, per quanto derivante da un abbaglio fondamentale, con l’essere radicato nella stessa essenza spirituale – che spirituale è, anche se, come affermato da papa Wojtyła, è il male assoluto – del nazismo.
Questo è vero per l’adesione a qualsiasi partito. Figurarsi quello ‘nazista’.
Ma il vero punto è che c’era una ragione più profonda per cui non si ‘giustificava pubblicamente’. Ed è che probabilmente non riusciva a ‘perdonarsi’ nel suo foro interno. In lui c’era sicuramente la υβρις di pensare: cosa mai possono capire gli altri del mio percorso di pensiero? Jaspers e la Arendt lo accusarono spesso di autogiustificazione facile e pusillanimità. Ma davvero poteva – proprio per l’orgoglio che lo contraddistingueva – sottrarsi privatamente alla domanda: come ho fatto io a sbagliare? E, infatti, che non riuscisse a perdonarsi facilmente per l’abbaglio lo mostrano i lunghi anni impiegati per riuscire a darsene conto. Cos’altro, infatti, è il Nietzsche (su cui lavorò quasi un decennio, per non contare tutti gli scritti successivi in cui è ritornato su quei temi) se non la propria personale resa dei conti con il suo abbaglio, con il fatto di non aver riconosciuto nel biologismo di Nietzsche l’anello che lo congiungeva con il nazismo (v. nel Nietzsche del nazista Bäumler il capitolo Il corpo). Collegamento Nietzsche-nazismo plaudito entusiasticamente dalla sorella, quell’Elizabeth Förster-Nietzsche, moglie di uno dei principali promotori (disprezzato da Nietzsche stesso) della dis-locazione razziale dell’anti-giudaismo, l’antisemitismo. Anello Nietzsche-nazismo alla cui demolizione è dedicato tutta la sua meditazione post-1934. Scrive già nel 1937 alla Blochmann: «In Nietzsche l’enigmaticità è spinta all’estremo. In quanto sprofonda…nel più rozzo biologismo…proprio nella più sconsiderata esagerazione…vuole qualcosa di totalmente diverso…e lo ottiene…senza saperlo organizzare nell’opera decisiva» [grass.;cors.- Φ].
Forse lui poteva ‘giustificarsi’; ma perdonarsi? Eppure c’era qualcuno che poteva farlo: Hannah Arendt. Sono ormai note le circostanze di quell’amour fou che legò nel 1925 il filosofo trentaseienne alla diciannovenne allieva, rotto dopo pochi anni. Così come sono note le vicende successive della Arendt, esilio nel 1933, matrimoni, produzione di filosofia politica in cui risuonano, ma rielaborati in autonomia, e con grande personalità, temi e richiami a terminologie del filosofo. Negli anni Quaranta, dopo la guerra, si era espressa ripetutamente in modo severo su Heidegger nelle sue lettere a Jaspers. Ma, all’inizio del 1950 accettò di rincontrarlo. Di questo incontro e del suo esito sono state date da alcune commentatrici versioni minimizzanti. Forse nell’ansia di irridere lui non si accorgono di insultare lei, attribuendole un modo di essere da donnetta. Come si fa a pensare alla Arendt, che si scioglie alla vista dell’antico amore? C’è stato Auschwitz di mezzo, e ci sarebbe potuta essere anche lei, come c’era stato il suo mondo.
Non vi è tribunale più severo per un uomo di una donna che l’ha amato a fondo e che si chiede chi abbia veramente amato. Se la donna è per di più intellettuale il tribunale diventa terribile. Se la donna oltre al resto è ebrea il tribunale diventa implacabile. Perché è la donna stessa a essere in giudizio. Lei deve sapere se ha commesso l’errore della vita; e qui l’errore sarebbe doppio: di cuore e di testa. Nessun anfratto verrà risparmiato, nessuna sfumatura resterà non scandagliata. Hannah Arendt, donna, intellettuale e ebrea, aveva tutte le ragioni e capacità per un simile processo. Solo lei poteva decidere sul peccato di Heidegger. Che la decisione sia stato un perdono ce lo dicono le parole scritte dopo l’incontro: “Questa sera e questa mattina sono la conferma di un’intera vita” [sott- Φ]. Conferma; non si era sbagliata ad amare Heidegger. È da questo giudizio e dal conseguente perdono che nascerà l’affetto che verrà, o tornerà, dopo il ‘giudizio’ (e non prima, secondo la versione da romanzetti rosa), come testimonia lo scritto per gli ottant’anni di Heidegger, “una volpe astuta ma priva di scaltrezza”, che “aveva passato tutta la vita in una trappola”.