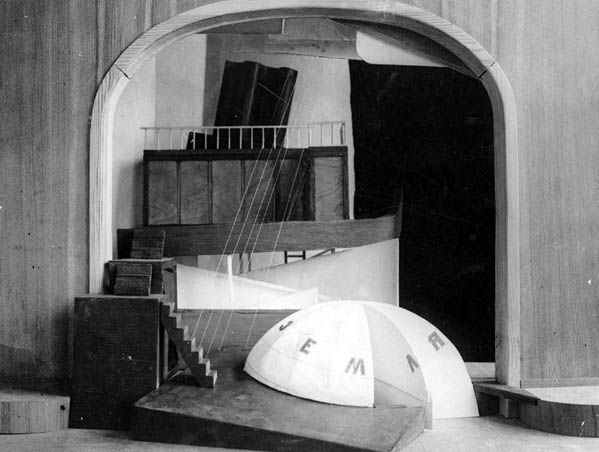voce/parola
A vent’anni dalla sua scomparsa, ricordare Fabrizio De André vuole dire ripensare anzitutto alla sua voce, prima che alle parole, a ciò che egli ha cantato. Passa da qui, del resto, la differenza tra la canzone d’autore (la sua “vecchia fidanzata”, come la chiamava) e una poetica. Non sono le parole, non è quello che egli ha detto cantando, a contare davvero. E ciò non soltanto perché – come è stato ricordato – a dispetto di quanto si tenda a pensare De André era «solito comporre prima la musica che le parole, e in attesa di aver finito il lavoro di “adattare un testo a una musica”, usava una parte dei suoi versi per riempire i vuoti» (Franco Fabbri). Dobbiamo, piuttosto, ricordarci sempre che la voce non è la parola. Essa, piuttosto, è ciò che la parola, una volta che interviene e si articola, abolisce, non fa più sentire; al contempo, però, è ciò che non potrebbe sentirsi se non attraverso la parola (Corrado Bologna ha scritto pagine bellissime su questo tema: la voce – vi leggo – «è l’indicibile che deve ammantarsi di panni verbali, addossarsi la carne del linguaggio per rendersi visibile»[1]). Per questo, come diceva Barthes, nella musica – per quanto possa essere studiata, tecnicamente, esteticamente, etc. – c’è sempre un resto, un non detto: la voce. Di Fabrizio De André, dovremo allora, forse, imparare a scoprire, prima di ogni altra cosa, quella “fisica della voce” che ha fatto dire a Umberto Fiori, molto giustamente, che «si potrebbe affermare che ciò che De André ha davvero creato è la sua voce, di cui testi e musiche costituiscono – per così dire – le condizioni d’ascolto». Se c’è allora una poetica, in De André, essa si definisce al limite, come scrive Valery, in quanto le langage issu de la voix, plutôt que la voix du langage. Non dobbiamo però confondere la voce con l’intonazione, il timbro, la pronuncia – per quanto abbia ovviamente a che fare con essi. La voce è ciò che sta tra il silenzio e il linguaggio, senza essere né l’uno né l’altro, condizione di ogni ascolto che non può essere ascoltata in quanto tale. Bisogna lasciarsi catturare dalla voce – ed è una cattura gioiosa, anche se essa non può farsi che a pezzi, frammentariamente, se richiede pazienza, perché non è facile sentirsi realmente, cioè fisicamente toccati da una voce. E’ un’esperienza propriamente amorosa, l’unica che si possa fare con il canto, con la canzone (non c’è esperienza “intellettuale” di una canzone: c’è forse del suo testo, o della sua musica, o di entrambi, ma non del canto in quanto tale). Certamente, c’è una scrittura raffinatissima, in De André, e ci sono anche tutte le sue “qualità” vocali. Ma il registro amoroso dell’ascolto non comincia che quando le parole diventano voce, quando si passa ad una vibrazione, in cui viene cancellato il linguaggio, la comunicazione, per un “pensiero fatto di sola voce” (per dirla con Gaunilone, la cogitatio secundum vocem solam[2]).
fuori-testo.
E’ come se tutto ciò che De André scrive, dice, canta – i “temi” delle sue canzoni – non fosse che al servizio di questa esperienza, non servisse che a portarci, ascoltandolo, fino al punto in cui si può incontrare la voce, quel fuori-testo che è quanto di più interno, in realtà, a ciò che è cantato. La voce è in eccesso, e che per questo si “intona” al di là del testo[3]. Si conquista allora, di volta in volta, la voce di Fabrizio De André, e per ciascuno questa conquista è diversa, perché passa per momenti, tratti che variano nel tempo. Per questo capita che per mesi interi si ascolti magari un solo disco, perché lì si sono individuati i punti, le inflessioni, le modulazioni che consentono di passare alla voce. Allora attraverso le parole si giunge finalmente a scoprire la voce, a sentirla sul proprio corpo (non so più, personalmente, che cosa De André dica, che cosa significhino punti come “cosa importa se sono fottuto, se sono lontano” o “si fermò un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i cazzi suoi”, nelle rispettive varianti introdotte nei concerti). La voce stessa diviene ciò che, fino a quel momento, era soltanto preparato, soltanto “annunciato” dal testo. Così l’alcolismo di “Amico Fragile” non è più una questione di parole, non passa più per il testo, ma è nella voce che si indurisce, voce puramente presente, in una perdita assoluta del passato, e che si articola intorno ad un “centro molle, lava, vetro liquido o pastoso” (questo “indurimento del presente” è, come Deleuze osserva, l’esperienza propria dell’alcolizzato). Così, ancora, in “Canto del servo pastore” – e più in generale tutte le volte in cui De André fa corrispondere il divenire-indiano del sardo con il divenire-sardo dell’indiano, è il grande tema dell’album del 1981 – , è la voce a farsi pellerossa, a guarire le ferite con il suo canto (lui stesso dirà: «La mia voce poteva essere una voce da sciamano»). E in “Crêuza de Mä”, la scelta della lingua – il genovese – serve a permettere alla voce di farsi voce-onda, voce-remo, voce-gabbiano («la lingua più adatta mi è sembrata il genovese, con i suoi dittonghi, i suoi iati, la sua ricchezza di sostantivi e aggettivi tronchi che li puoi accorciare e allungare quasi come il grido di un gabbiano»). Il rischio – che vi è sempre stato – di portare De André nelle antologie scolastiche, di valorizzarne la “poetica”, è dunque quello di non capire più, di invertire – e così semplificare – il rapporto tra voce e parola. La voce non è il mezzo di espressione della parola, lo “strumento” per comunicare qualcosa. Al contrario, sono le parole che preparano la voce, la sua emergenza, i suoi divenire, ed il suo forzarci, portarci altrove. “Dolcenera” non racconta di un amore perduto e di una morte durante un’alluvione se non per consentire alla voce di farsi a sua volta pioggia, di “picchiare forte”. Bisogna seguire questi divenire della voce, attraverso il canto: voce che cade come neve, in “Inverno”; voce che non canta mai l’abbandono, ma che diviene l’abbandono stesso (“Tre madri”); voce che diventa oggetto perduto, diventa ciò che causa il nostro desiderio (“D’ä mæ Riva”). L’arte di De André è inseparabile da tutto questo, e la sua “discografia”, le diverse “influenze” (dagli chansonniers francesi alla musica americana), le “alleanze” che ha stretto (da Dané a Piovani, a Bentivoglio, a Pagani, etc.) non andrebbero studiate che come pratiche, come tentativi di sperimentare ciò che poteva la sua voce: le affezioni che poteva provocare e subire, le forze che poteva mettere di volta in volta in gioco.
voce-sesso
Poche voci sembrerebbero “maschili” come quella di De André. Ma che cos’è una voce maschile? Pascal Quignard parla, in maniera meravigliosa, di come essa sia sempre una voce che si è rotta, perduta: solo l’uomo perde la voce, la sua voce di bambino, in corrispondenza con la vernatio, la “sessuazione” e la divisione tra i due sessi, la sua muta durante la pubertà (Adolescent, comme tous les adolescents, ma voix se brisa. Mais elle demeura étouffée et perdue). E’ allora che la voce si fa bassa, che cessa di essere la “mia” voce. La voce maschile è una pelle di serpente, è voce morta, strappata all’infanzia, alla sua “femminilità”. Per questo il femminile, in De André, è sempre dalla parte del sacrificio (lo ripeterà spesso: «per me il mondo della donna è sempre apparso, almeno ai miei occhi, come un po’ il mondo del sacrificio», il sacrificio della maternità, della prostituzione e della verginità), di ciò che è stato sacrificato nel farsi-maschile della voce. Solo la voce femminile, propriamente, canta, è la voce del canto (Hélène Cixous: «quello che canta in un uomo non è “lui”, è “lei”»). Ma, se nella donna il canto è ciò che preserva questa voce, per il maschio essa è una voce perduta per sempre, una voce sacrificata. Egli non farà musica che per ritrovarla. Si pensi alla “Buona Novella”, nella sua prima parte, soprattutto con l’infanzia e il sogno di Maria: non si tratterà mai che di cantare la perdita di un canto femminile, il suo sacrificio che precede quello della croce.
voce-evento
Elio Matassi lo ha ricordato con precisione: la concezione della voce come strumento (ossia «quella concezione che considera la voce alla stregua di un puro oggetto, declinabile a piacimento da una volontà ad esso totalmente estranea») è all’opposto della concezione della voce come evento, in cui «definire la voce un evento significa considerarla una dimensione straordinaria che nasce e muore nel momento stesso in cui accade e che, pur in questa sua istantaneità, celebra una svolta decisiva»[4]. Di questo, dunque, si tratta, per poter incontrare De André: di lasciare che la sua voce possa accadere. Si esce allora dalla musica attraverso la musica, si esce dal testo attraverso il testo, per poter arrivare alla voce, ad un pensiero che non passa per le parole, per i loro significati, ma che è fatto di pura voce, flatus vocis. La voce è ciò che può essere raggiunto solo dove la parola finalmente manchi. La voce, a differenza della parola, è ciò che non inganna (perché non significa), non comunica nulla – non passa alcuna informazione, per essa. Quel che non coglie il punto, allora, è la retorica del De André “poeta” – a cui spesso, è vero, siamo stati tutti tentati di ricorrere (alcune dichiarazioni di Luzi, di Tabucchi, il quale scrive che i suoi «testi sussistono alla perfezione sulla pagina senza obbligatoriamente l’appoggio della musica», o della Pivano, che ne parlò come del «più grande poeta che abbia avuto l’Italia negli ultimi cinquanta o sessant’anni»). Ma questo perché la canzone non è semplicemente l’unione estrinseca, l’accordo di testo e musica, non è semplicemente un testo cantato. La canzone è, piuttosto, ciò che lascia venire la voce, ed è solo tramite la voce – osservava Bachmann – che la poesia, il detto e la musica trovano, nel reciproco richiamarsi e relazionarsi, il loro momento di verità (an dem Dichtung und Musik den Augenblick der Wahrheit miteinander haben). Se De André si è servito, allora, della canzone – e, anzitutto, delle strutture della chanson, o della ballata – è perché si trattava, più di ogni altra cosa, di dar corpo alla voce, di consentirle di incarnarsi, di farsi sensibile. Proprio perché non esiste che nel suo incarnarsi, nelle note, nei suoni, che la voce non è semplicemente quella di De André (ciò che egli dice): la voce è il resto, è forse, al limite, la sua assenza, il vuoto stesso che il cantato lascia sentire – sono i punti di rottura, dove la canzone non è più discorso, dove passa vicinissima al silenzio. Per questo la voce non si oppone, ma è inseparabile da ciò che è senza voce. Ed è in questo senso che De André “canta” gli ultimi, coloro che non hanno voce.
senza-voce
Tutto il tema “politico” non passa
infatti che da qui, ed è veramente poca cosa ripetere che De André è stato il
cantante degli “ultimi”, degli “esclusi”, dei diseredati. Il punto, piuttosto,
è che, se egli ha parlato “per” loro, lo ha fatto proprio a partire da questa
domanda: come farsi una voce per parlare in nome di coloro che sono senza-voce
– che siano essi quanti “morirono a stento”, o le “anime salve”? C’è una voce
che si fa pura lontananza, distanza, pura “feritoia della notte” ad esempio, e
che è la voce dei suicidi, o meglio una voce-suicida (si pensi a “Preghiera in
gennaio”). Se allora c’è una politica, in De André, essa non si definisce che
in questo movimento – del tutto interno alla canzone: rendere udibile ciò che
non è udibile, ossia la voce dei senza-voce. In questo senso, è ad un
senza-voce ciò a cui la voce di De André riesce ad arrivare, un silenzio che è
quello di chi non ha mai avuto la parola (la lingua dei vinti). “Storia di un
impiegato” è forse il disco dove si gioca in maniera più evidente questa lotta
tra la parola e la voce, in quella reciproca implicazione (nessuna parola senza
voce, nessuna voce che non parli) che ne nasconde la differenza. Tutto passerà
per variazioni sottilissime, allucinazioni in cui bisogna esercitarsi a entrare
per capire quando si passa dalla parola – ossia dal linguaggio del potere,
gelido, “neutro”, informativo e giudicante (“Sogno numero due”) – alla voce –
disarticolata e visionaria, e pure sempre ferma, crudele e dolce (“vostro onore
sei un figlio di troia”). Che, poi, sia in De André che tutto questo avviene
con maggior rigore rispetto ad ogni altro “cantautore”, ciò lo si deve forse,
come ha osservato ancora Franco Fabbri, a quella «faglia nella voce» che fa sì
che, in lui, vi siano sempre due registri, due “voci” – l’una più grave, che
risuona «dentro lo stesso ascoltatore», l’altra più narrativa, “pubblica”, più
asciutta[5].
Blanchot aveva già distinto la voce “narrante” – quella che rinvia al soggetto
che racconta – dalla voce “narrativa” – voce del “neutro”, sempre differente da
ciò che la proferisce. E’ la continua interazione, differenziazione, eterogeneità,
tra queste due voci che spezza la “parola”, il semplice comunicare qualcosa
della canzone, il testo, che lo “buca” sempre, fa sentire la propria mancanza,
lo attraversa come una pura intensità. Il problema non è allora che non si
possa “imitare” la voce di De André (lo si fa in continuazione, ormai, perché
imitare De André, paradossalmente, è semplicissimo, come ancora Fabbri
ricordava, di recente: chiunque riesca a scendere con la voce fino al mi basso
della chitarra «somiglierà inevitabilmente all’originale, per il solo fatto di
scendere ai limiti inferiori della propria estensione»). E’ che non è nella voce – ossia nella sola tonalità,
nel timbro – che sta la voce. La voce è ciò che richiede un lungo lavoro di
creazione, è ciò che può essere raggiunta soltanto dall’artista, e non dal
cantante dilettante. Se allora Fabrizio De André non verrà dimenticato – e
questa dimenticanza rischia di passare, in realtà, proprio dalla sua
celebrazione, dal suo essere divenuto un “autore” antologizzato –, tutto
dipenderà ancora dalla nostra capacità di saper ascoltare la sua voce, di
sapersi innamorare di lei, di lasciarsi ferire da essa, di essere nel suo
abbandono. «E’ la voce che ti viene confidata, e non ciò che dice»[6].
[1] C. Bologna, Flatus vocis. Metafisica e antropologia della voce, Bologna, Il Mulino, 1992.
[2] Il motivo è stato ripreso e sviluppato da G. Agamben, Il linguaggio e la morte, Torino, Einaudi, 1982.
[3] Cfr. A. Cavarero, A più voci. Filosofia dell’espressione vocale, Milano, Feltrinelli, 2003.
[4] E. Matassi, La voce come evento, in «Lettera internazionale», 89, 2006, pp. 51-53.
[5] Cfr. F. Fabbri, Il suonatore Faber, in Id., L’ascolto tabù, Milano, Il Saggiatore, 2017.
[6] M. Blanchot, L’attesa, l’oblio, trad. it. Parma, Guanda, 1978, p. 22.