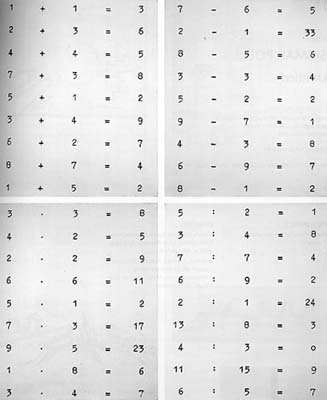Mi ha molto colpito l’incipit di un bell’articolo che Ernesto Sferrazza Papa ha scritto qualche tempo fa per questo Periodico.
In particolare Ernesto ha dichiarato, in apertura: “La complessità dello spazio globale che abitiamo, troppo complessa per poter essere trattenuta in immagine, troppo sclerotizzata da farsi sussumere nella forma del concetto, può suggerire la necessità di attraversarla nella forma della suggestione. Un pensiero non sistematico, ma non per questo irrazionale o “poetico”, composto perlopiù da una serie di appunti, di note prese durante un lucido dormiveglia”.
Cioè, la complessità (dello spazio globale, ma il discorso varrebbe per qualsiasi complessità) è – parrebbe quasi banalmente – “troppo complessa per essere trattenuta”, per essere sussunta nella forma di un concetto. Talmente complessa è la complessità (si perdoni il giuoco), da richiedere un metodo di indagine in grado di “attraversarla” mantenendo la sua dynamis, la sua tendenza al movimento, il suo conatus, che non può sopportare la subordinazione ad un pensiero sistematico, la sottoposizione alla fatica del concetto formalmente elaborato. Questa – la complessità – richiede, per essere com-presa (comprehendere) un pensiero che si basi su suggestioni, appunti, note. Non un un guazzabuglio irrazionale e inspiegabile di parole confuse, non un sogno elegiaco, come accadeva a quei poeti che Socrate rimproverava poiché non erano in grado di dare un senso alla loro ispirazione – e quindi a quel reale cui l’ispirazione li aveva condotti[1].
Questo l’incipit molto forte e molto lucido, per nulla suggestivo, di Ernesto Sferrazza. Quasi, a parere di chi scrive, un oltre-passamento della dichiarazione d’intenti da parte del suo autore – quasi un’annotazione di metodo, in linea con un diverso intendimento del linguaggio della politica e del diritto (e in fin dei conti, più ampiamente, della filosofia).
Una filosofia diversa: l’annotazione di metodo, si badi, può essere formulata – e Sferrazza lo fa – come se si trattasse di un metodo universale, astratto e generale, per accedere al reale (ad ogni reale e alla sua complessità) senza trascurarne l’intrinseco movimento, la connaturata vitalità, la imperitura spontanea continua evoluzione. Un metodo che parrebbe necessario, e non solo sufficiente: necessario nel senso che riducendo la dynamis complessa del reale a simulacri concettuali di ordine formale (il lavoro del concetto, la fatica del concetto, l’ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti[2]) si perderebbe il reale stesso – di cui non rimarrebbe che un concetto formale[3]. Ma la sua vitalità, la sua complessità andrebbe perduta.
L’unico metodo capace di man-tenere la vitalità del reale (e della sua complessità) sarebbe quindi la suggestione, un pensiero non irrazionale e non sistematico in grado di attraversare la complessità senza trattenerla in una (sola) immagine fotografica, in un solo fotogramma, nella fissità di un istante in sé conchiuso.
Il punto è questo: che cos’è una suggestione?
Certo, riferirsi all’etimo, in questo caso, risulterebbe del tutto fuorviante.
***
«J’allois voir Diderot alors prisonnier à Vincennes; j’avois dans ma poche un mercure de France que je me mis à feuilleter le long du chemin. Je tombe sur la question de l’Académie de Dijon qui a donné lieu à mon premier écrit. Si jamais quelque chose a ressemblé à une inspiration subite, c’est le mouvement qui se fit en moi à cette lecture; tout-à-coup je me sens l’esprit ébloui de mille lumieres; des foules d’idées vives s’y présentent à la fois avec une force, & une confusion qui me jetta dans un trouble inexprimable; je sens ma tête prise par un étourdissement semblable à l’ivresse. Une violente palpitation m’oppresse, souleve ma poitrine; ne pouvant plus respirer en marchant, je me laisse tomber sous un des arbres de l’avenue, & j’y passe une demi-heure dans une telle agitation, qu’en me relevant j’apperçus tout le devant de ma veste mouillé de mes larmes, sans avoir senti que j’en répandois. Oh, Monsieur, si j’avois jamais pu écrire le quart de ce que j’ai vu & senti sous cet arbre, avec quelle clarté j’aurois fait voir toutes les contradictions du systême social; avec quelle force j’aurois exposé tous les abus de nos institutions; avec quelle simplicité j’aurois démontré que l’homme est bon naturellement, & que c’est par ces institutions seules, que les hommes deviennent méchans. Tout ce que j’ai pu retenir de ces foules de grandes vérités, qui dans un quart-d’heure m’illuminerent sous cet arbre, a été bien foiblement épars dans les trois principaux de mes écrits, savoir ce premier discours, celui sur l’inégalité, & le traité de l’éducation, lesquels trois ouvrages sont inséparables, & forment ensemble un même tout»[4].
Jean Starobinski, che coglie lo spunto autobiografico suggerito dallo stesso Rousseau nel brano sopra riportato[5], non solo ricollega giustamente il contenuto dell’ispirazione improvvisa alla futura intera produzione rousseauviana, ritenendolo il primo mattone di quell’edificio che poi lo stesso Rousseau costruirà con forza e pertinacia negli anni a venire, ma, commenta, con un accento che qui interessa in modo preponderante: «L’illuminazione lungo la strada di Vincennes (…) non possiede il carattere della pienezza affermativa che sarebbe stata propria dell’ispirazione “apollinea”. Anche se la “confusione”, il “turbamento” e soprattutto l’”ebbrezza” sono tratti che appartengono alla tradizionale descrizione dello stato di entusiasmo lirico, troppi sono gli indizi di cui disponiamo per non riconoscere che, in questo caso, si tratta di un’estasi assai diversa dagli stati passionali (…) conosciuti e descritti da Rousseau in altre occasioni»[6].
Cioè, non solo l’ispirazione improvvisa è da ricollegare assolutamente all’intera produzione rousseauviana – quindi non si è trattato di un sogno patetico, irrazionale – ma quell’ispirazione, quella medesima ispirazione, corrisponde ad un’estasi particolare, ad un’estasi diversa.
Una suggestione, diremmo noi.
Rousseau, in definitiva, stando al suo racconto autobiografico, ha attraversato la complessità con una suggestione che poi si sarebbe trasformata in una sequela di concetti formali e formalizzati, nella ricerca di un’intera vita.
Tuttavia, non ci interessa in questo momento il collegamento tematico tra la produzione rousseauviana matura e l’ispirazione improvvisa sulla strada di Vincennes, ma solamente la resa mitica con la quale Starobinski inquadra, opportunamente, l’estasi suggestiva di Rousseau – che in questo caso, siccome interessa solamente dal punto di vista dell’esperienza suggestiva (la pratica della suggestione), poteva essere di Rousseau, di Ernesto o di Fabio. Interessa qui solamente l’ebbrezza il turbamento la confusione astratta. Perché è il turbamento a produrre la suggestione, le “note prese durante un lucido dormiveglia” di cui parla Sferrazza.
Si potrebbe dire quindi che la suggestione corrisponde ad un turbamento metodologico in grado di ingenerare pensieri astratti e generali dai quali potrebbero discendere dei concetti formali, ma non è detto che questo accada obbligatoriamente – o meglio, se accadesse, la fatica del concetto formale potrebbe essere collegata alla prima intuizione, alla ebbra suggestione iniziale, solamente dal fatto che a formularla è sempre la stessa persona, quella che ha esperito la suggestione.
***
Ora, può la suggestione essere uno strumento adatto alla conoscenza, oppure, più del suo aspetto teoretico, importa la sua portata politica (di una politica della conoscenza)?
È evidente che questa domanda così impegnativa non può essere evasa in poche righe, attraverso una risposta definitiva di congedo.
Si propongono, piuttosto, a mo’ di suggestione, alcuni disparati interrogativi, che vedono la luce dopo alcune riflessioni maturate in forma di appunti, “durante un lucido dormiveglia”.
***
La suggestione, il procedimento per suggestione, come si è detto e come si può immaginare, produce pensieri e riflessioni astratte e generali, pensieri e riflessioni in corsivo, pensieri e riflessioni quasi del tutto privi di riferimenti bibliografici, pensieri e riflessioni evocativi, ridondanti, non-analitici, non-scientifici nel senso attribuito generalmente correntemente e accademicamente al pensiero scientifico.
Nessuno mette in discussione la necessaria rigidità del linguaggio e delle convenzioni scientifiche, ma è possibile che anche il pensiero suggestivo sia in grado di fornire un valido contributo lungo la via della conoscenza?
È obbligatorio premettere che questa provocazione estiva non vuol ammiccare in alcun modo alla filosofia pop, ai filosofi in tivù, o sui rotocalchi. Non perché non sia degno di un filosofo esprimersi su un settimanale patinato, ma solamente perché si sta parlando di un’altra cosa, di un altro tipo di esperienza della scrittura e dell’intuizione[7].
L’intuizione che si rivela nella forma della suggestione potrebbe essere prodromica alla conoscenza scientifica “classica”, oppure rimanere una semplice irruzione nel movimento del reale senza successive specificazioni in grado di trasformarla in una teoria concettualmente giustificabile, ma in ogni caso è un’intuizione assolutamente non-mondana. Non perché rifugga il grande pubblico, ma perché è il grande pubblico a rifuggirla, proprio a causa di quei caratteri di astrattezza e generalità che la fanno gravitare nell’ambito dei pensieri difficili da proporre in forma accessibile: come la poesia, la suggestione non è altrimenti spiegabile. Possiede un suo linguaggio specifico che in qualche modo caratterizza anche le regole per potervi accedere. Il suo linguaggio corrisponde anzi proprio alle possibilità di non rivelarlo, alla sua garanzia di impronunciabilità in modi e sensi diversi. Con un’immagine che si potrebbe definire deleuziana, la suggestione non può essere s-piegata ma solo ri-piegata: s-piegarla significherebbe alterare quel linguaggio originario che ne determina la purezza e che tuttavia ne consente la comprensione; ri-piegarla significherebbe invece unicamente riprendere la piegatura originaria del discorso, senza volerlo adulterare attraverso s-piegazioni integrative[8]. La s-piegazione della suggestione potrebbe provocare o la sua trasfigurazione in concetto oppure il suo travisamento, il tradimento della sua efficacia aurorale. Il ri-piegamento ne garantirebbe viceversa la normalità, porterebbe a riconsiderare la sua piegatura embrionale, la sua originalità ed originarietà, il suo stare all’origine del pensare.
***
È quasi naturale collegare mentalmente quanto sinora scritto ad alcuni passaggi della celebre Lettera VII, in cui Platone si riferisce alla verità che «brilla improvvisa nell’anima, come la fiamma della scintilla, e di se stessa in seguito si nutre»[9], quella verità che non può essere scritta ma solamente detta e nemmeno riferita da parte di chi l’avesse sentita rappresentare verbalmente. La suggestione in fondo mantiene questa difficoltà d’accesso: può essere pensata improvvisamente, attraverso un turbamento, può essere annotata in forma di appunti, nel lucido dormiveglia, nel chiarore pallido dell’ebbrezza, ma non può essere altrimenti spiegata, se non affidandosi a quanto già elaborato da parte di colui che l’abbia esperita. È questo il senso dell’impossibilità di spiegazione di una suggestione. Quando venisse spiegata, quand’anche raggiungesse l’onore del concetto, non sarebbe più, comunque, una suggestione. Verrebbe meno, a fronte di un aumento della sovraesposizione luminosa del concetto formalizzato.
La suggestione-lucciola: non può convivere con fonti luminose troppo intense; è impossibile intrappolarla in una mano per non farla fuggire e allo stesso tempo apprezzarne la lieve luce che emanerebbe, quando fosse liberata; non può essere fermata per stimarne la seppur debole capacità luminescente ― «per conoscere le lucciole bisogna vederle nel presente della loro sopravvivenza: bisogna vederle danzare vive nel cuore della notte, anche se quella notte viene spazzata via da qualche feroce riflettore. E anche se è per poco. E anche se c’è poco da vedere»[10].
La luce minore delle lucciole è dotata di una pallida forza luminosa che può essere considerata esclusivamente nella sua dynamis, non può essere fermata, bloccata, arrestata, può essere colta solo nel suo lento ed inesorabile fare.
Qui si coglie l’aspetto più potentemente politico della suggestione-lucciola: la luce minore che non può convivere con le luci maggiori, che non tollera la sovraesposizione luminosa è una vita che pare in via di estinzione, corrisponde ad un modello di esistenza che non tollera la continuata accecante radiazione luminosa, ma si nasconde nelle esangui intermittenze della vita, nel chiaroscuro delle ombre e delle piccole luci che formano l’esistenza, nelle pieghe dei tessuti connettivi della società.
In un’epoca che osanna la luce e la luminosità, che acclama la purovisibilità, che adora il bagliore ininterrotto che favorisce un piena osservazione di tutti gli aspetti della vita al fine di sottoporla ad una forma di controllo che si potrebbe definire panoptico, totale, cercare la luce minore, inseguire le lucciole, corrisponde ad un atteggiamento lirico ed allo stesso tempo rivoluzionario. Ha il sapore dell’attesa fiduciosa che non si vuol concretare inderogabilmente in un concetto formale, ma vuol mantenere il senso dell’intervallo, della sospensione, dell’intermezzo, dello stacco ― dell’intermittenza durante la quale avviene ciò che appare invisibile ai fasci luminosi accecanti della vita sovraesposta. Ed allo stesso tempo reclama la potenza di quell’intervallo, ne tributa l’importanza ai fini di una più approfondita conoscenza del reale, che non si esaurisce nel positum lucente dell’iridescenza artificiale dei concetti. Qui la sua patente politicità.
Assistere alla marcia nuziale delle lucciole[11], attendere il presentarsi della suggestione: sono momenti di un turbamento trasognato, di un’ebbrezza destinata a terminare come terminano i sogni, come se si trattasse di una battuta di caccia alle chimere ― quando il sogno svanisce non ne rimane che una vaga impressione che deve essere costantemente richiamata per rallentare la dissolvenza. Ecco il ruolo attivo del filosofo: rallentare la dissolvenza della suggestione e attraversarne il movimento, l’ombra del movimento originario che non può essere trattenuto!
La suggestione in effetti somiglia alla chimera, nel senso di Andrea Emo, autodefinitosi cacciatore di Chimere, o nel senso di Dino Fontana: poesia, ispirazione lirica, suggestione, ebbrezza ― “Regina de la melodia”, la chimera non può che essere chiamata e richiamata dal poeta, in attesa che si presenti tra “le stelle vivide nei pelaghi del cielo”, quando la sua dissolvenza non ha lasciato che un’immagine sfuocata della pur debole luce che irradiava.
Non so se la fiamma pallida
Fu dei capelli il vivente
Segno del suo pallore,
Non so se fu un dolce vapore,
Dolce sul mio dolore,
Sorriso di un volto notturno:
Guardo le bianche rocce le mute fonti dei venti
E l’immobilità dei firmamenti
E i gonfii rivi che vanno piangenti
E l’ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti
E ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti
E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera [12].
[1] La poesia è un linguaggio che tende al reale attraverso quella parola e solo quella parola che viene negata ad altri. Saramago in qualche luogo della sua vasta produzione ha correttamente osservato che non si può chiedere al poeta di utilizzare un altro linguaggio (un linguaggio-altro) per spiegare diversamente quello che ha già dichiarato con una poesia: se fosse possibile, l’avrebbe già fatto! Questo aspetto della poesia come strumento di accesso al reale potrebbe essere approfondito in una serie di riflessioni dedicate ad esempio alle lezioni francofortesi della Bachman.
[2] D. Campana, La chimera, in Canti Orfici, 1913.
[3] Per continuare con l’immagine campaniana, L’ombre: l’ombra del lavoro, il concetto formale del lavoro e non il lavoro stesso, la sostanza “materica” del lavoro.
[4] J.-J. Rousseau, Seconde lettre à M. le Président de Malesherbes, Montmorenci le 12 Janvier 1762.
[5] “Tout ce que j’ai pu retenir de ces foules de grandes vérités, qui dans un quart-d’heure m’illuminerent sous cet arbre, a été bien foiblement épars dans les trois principaux de mes écrits, savoir ce premier discours, celui sur l’inégalité, & le traité de l’éducation, lesquels trois ouvrages sont inséparables, & forment ensemble un même tout” (Ibidem)
[6] J. Starobinski, Jean Jacques Rousseau. La trasparenza e l’ostacolo (1972), trad. it., Il Mulino, Bologna 1982, p. 11.
[7] Il filosofo che emerge da un settimanale patinato propone nondimeno un’esperienza del tutto inversa: deve spiegare ciò che non richiede spiegazioni semplificatrici ma approfondimenti tematici e analitici, ovvero il concetto; il procedimento di ostensione del pensiero al grande pubblico parte proprio dal concetto (nel senso che il concetto costituisce il suo unico referente) e ne ripercorre taluni elementi costitutivi, per renderlo più facilmente appetibile, più digeribile, quasi a sottolineare il motivo della fatica che lo ha composto. La suggestione è invece materia indigesta, non è appetibile e non è nemmeno scomponibile: non è diretta alla miglior comprensione, all’ostensione. Il settimanale patinato, sia per questioni editoriali che per ragioni di diffusione non può essere la patria del corsivo, non consente un’estensione altalenante dei periodi, richiede una lunghezza precisa in caratteri, né più né meno. La suggestione è invece un lungo corsivo, non può che essere un lungo corsivo, una forma altra della scrittura; non permette di essere riducibile ad un determinato numero di caratteri: potrebbe essere espressa in forma di aforismi (in questo senso, ad esempio, gli aforismi di Canetti sono veramente una dimostrazione della mancanza di forma del pensiero suggestivo). Con un pizzico di malizia si potrebbe arrivare ad affermare che il filosofo in tivù o sui settimanali, il filosofo pop, alla moda, traduce i concetti in conversazione culturale, relativizza i concetti: non produce conoscenza in senso stretto, non aumenta l’analisi, ma la impoverisce proprio per renderla comprensibile, appetibile, digeribile; la suggestione opera in modo contrario: assolutizza i concetti per superarli, produce un espansione della riflessione e stimola l’analisi, la eccita. La domanda rimane: se è pacifico che l’articolo di argomento filosofico pubblicato su un settimanale patinato non può essere considerato una forma di conoscenza scientifica, ma solo di approfondimento culturale tanto quanto una rubrica dedicata a “Costumi e Società”, ad esempio, qual è la connessione tra la conoscenza scientifica intesa in senso stretto ed il procedimento per suggestione?
[8] S-piegare, giocando con le parole, significa evidentemente togliere la piegatura originaria, proporre un’altra piegatura.
[9] Platone, Lettera VII, 341d
[10] G. Didi-Huberman, Come le lucciole (2009), trad. it., Bollati Boringhieri, torino 2010, p. 33.
[11] È questa la bella immagine elaborata da Didi-Huberman per sottolineare l’”erotismo” del richiamo luminoso. Erotismo platonico che ricorda molto le belle pagine del Simposio.
[12] D. Campana, La chimera, in Canti Orfici, 1913.




 I. Anzitutto si deve far notare che è stata la “realtà virtuale” a fagocitare la “realtà sociale” e non il contrario
I. Anzitutto si deve far notare che è stata la “realtà virtuale” a fagocitare la “realtà sociale” e non il contrario II. Confusione, illusione, abolizione della distanza: «l’eccessiva vicinanza dell’avvenimento e della sua diffusione in tempo reale crea un’indecidibilità, una virtualità dell’avvenimento che lo priva della sua dimensione storica e lo sottrae alla memoria» e prima ancora lo svuota del suo carattere reale, sostanziale e tragico, lo de-sostanzializza sottraendone proprio l’insorgenza del tragico: «oggi il tragico si è dissolto nel nulla di quella falsa identità di società e soggetto il cui orrore balena ancora fuggevolmente nella sua vuota apparenza», e così «la liquidazione del tragico conferma quella dell’individuo»
II. Confusione, illusione, abolizione della distanza: «l’eccessiva vicinanza dell’avvenimento e della sua diffusione in tempo reale crea un’indecidibilità, una virtualità dell’avvenimento che lo priva della sua dimensione storica e lo sottrae alla memoria» e prima ancora lo svuota del suo carattere reale, sostanziale e tragico, lo de-sostanzializza sottraendone proprio l’insorgenza del tragico: «oggi il tragico si è dissolto nel nulla di quella falsa identità di società e soggetto il cui orrore balena ancora fuggevolmente nella sua vuota apparenza», e così «la liquidazione del tragico conferma quella dell’individuo»

 III. Ma qual è l’area relazionale della normatività legata al nome di Don Draper?
III. Ma qual è l’area relazionale della normatività legata al nome di Don Draper?